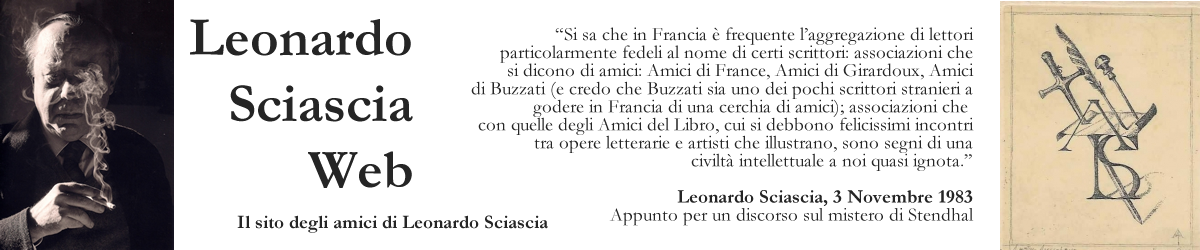Non seccherà più. Spero di no, ma è possibile che questo impietoso pensiero abbia sfiorato la mente dei tanti avversari di Leonardo Sciascia, adesso che i suoi occhi si sono chiusi per sempre. Nessuno come Lui è riuscito ad attirarsi tante ostilità e, quel che è più sorprendente, a volta a volta nel campo che, in occasione della precedente sortita, sembrava gli fosse favorevole: forse era affetto da inguaribile spirito di contraddizione o forse tentava di essere semplicemente un uomo libero e imparziale, un giusto. Ma, si sa, questa professione da noi è quasi sconosciuta.
La tempesta cominciò a ribollire quasi vent'anni fa, nel 1971, all'epoca del «Contesto», impressionante premonizione di quello che, sette anni dopo, diventò la scena del caso Moro. Se non ricordo male, toccò ai comunisti di prendere cappello, ai comunisti che si sentirono imputati d'essere un partito rivoluzionario ben deciso a non fare la rivoluzione. Nel 1975, dopo un riavvicinamento allo schieramento capeggiato da Berlinguer, fu consigliere comunale a Palermo come indipendente nelle liste comuniste; ma due anni dopo si dimise. Non gli piaceva il compromesso storico, non gli piaceva la quiescenza, quella che assumeva d'essere una forza progressista; sconsolatamente commentò: «Mi chiedo quando il Partito comunista italiano comincerà a dire di no...».
La vicenda Moro lo sconvolse e fu un brutto frainteso averlo accusato (come fece «Paese Sera») di non voler prendere posizione davanti alla tragedia. Ripensando alle pagine di Todo modo, Sciascia dichiarò più tardi di non sentirsi più libero di immaginare, di aver paura di dire cose che possono avvenire. Alla fine dell'estate del 1978 L'affaire Moro testimoniò il suo rovello e il suo convincimento che ben poco si fosse fatto per risolvere un enigma angosciante; pur senza sottoscrivere tutte le tesi del «Pamphlet», bisogna ammettere che l'enigma è rimasto insoluto in tutti i suoi aspetti più scuri.
Parimenti allarma la lettura suggerita da Sciascia in uno dei passi più famosi dei messaggi spediti da Moro durante la carcerazione, quello in cui si parla di un «dominio pieno e incontrollato» dei terroristi, espressione che, in linguaggio non criptico, potrebbe significare «un condominio affollato non ancora visitato dalla polizia». Un'interpretazione fantasiosa (speriamo), che tuttavia fa sorgere il tremendo dubbio che Moro abbia tentato di segnalare una pista da battere e che non sia stato capito.
La baruffa sull'antimafia è di ieri. Forse la baruffa più incresciosa e per certi versi più vergognosa, perché indusse alcuni polemisti frettolosi a sollevare, a carico di Sciascia, quasi un dubbio di convivenza mafiosa. Amara apoteosi di una vita interamente spesa per combattere qualsiasi potere e, più che mai, qualsiasi potere occulto; mentre Sciascia, che aveva esperienza di rivoluzionari restii alla rivoluzione, contrastava non certo la lotta alla mafia bensì il modo di condurre tale lotta. Che, come tutti sanno, esige polizia, tribunali, organismi specializzati, ma, più di tutto, postula una coerenza morale che è sconosciuta in Sicilia come nel resto d'Italia.
Giudicare il cittadino Leonardo Sciascia a prima vista può sembrare difficile: la difficoltà, squisitamente italiana, sta nell'impossibilità di incasellare la sua esperienza civile, nell'assurdità e nell'incongruenza di ogni etichetta: in un Paese come il nostro, che da circa settant'anni affida alle tessere la fortuna e il futuro dei suoi figli (prima in regime di monopolio e adesso di oligopolio), una creatura come Sciascia può davvero lasciare attoniti. E può suggerire la più losca dietrologia, come accade tra donne di piacere che sorprendono a passeggiare sul marciapiede una ragazza di buona famiglia.
Non lo si dirà mai abbastanza alto: Sciascia era un puro. Ed era un ingenuo, un utopista, un don Chisciotte, come lasciano trasparire tanti riferimenti nei suoi scritti. Il panorama politico italiano non poteva piacergli, come non poteva piacergli una certa sinistra sempre pronta a compromettere, a palleggiare e, perché no, a ripartire le spoglie. L'epicentro della tragedia mafiosa per Sciascia già da molto tempo si era spostata da Palermo a Roma: se nella nostra capitale almeno per adesso la lupara mozza non si fa sentire, è pur vero che l'amministrazione della cosa pubblica, al centro prima che in periferia, è degradata in un volgare accordo di lottizzazione nell'assenza di ogni serio progetto politico.
In questo contesto (è proprio il caso di dirlo) essersi scandalizzati per gli strali nei confronti dell'antimafia dimostra almeno ingenuità, tanto più che il problema del potere, nella concezione di Sciascia, deve essere riguardato unitariamente, non essendovi un potere buono e un altro cattivo, ma essendovi sempre e comunque una sopraffazione del più forte a danno del più debole. Date queste premesse, non si vede perché dovrebbe meglio piacere un sopruso piuttosto che un altro; e la legge sui pentiti, che tanto indignò Sciascia, di soprusi ne ha determinati parecchi.
Sia come si vuole, adesso che Egli è morto, ragionare di terrorismo, di mafia, di corruzione, della bassa cucina in cui viene rimestata la nostra vita pubblica, appare quasi oltraggioso. Leonardo Sciascia era prima di tutto un grande letterato, un grande scrittore e, tutto sommato, non amava la politica: la subiva come un male inevitabile, la subiva per amor di giustizia e per difendere i più deboli come conveniva all'ultimo incompreso, infelice don Chisciotte.
Detestava quelli che si fanno forti dell'amicizia giusta, che truccano le carte in tavola, che non pagano le tasse a scapito degli onesti, che rivendicano il diritto di essere furbi. Nei suoi pensieri il compromesso storico, il pentapartito, le angustie battesimali dei comunisti erano la squallida cosa che sono; con questa democrazia, con questa civiltà aveva chiuso i conti da un pezzo e confidava, sempre più accoratamente, in un mondo emendato dal peccato mafioso, che è peccato universale e non solo siciliano. Era sempre più consapevole di vivere in una società dove si fronteggiano, riprendendo l'immortale formulazione orwelliana, gli eguali e i più eguali degli altri: la sua ideologia si compendiava nell'avversione ai più eguali degli altri.
(dal Corriere della Sera, 21 novembre 1989)