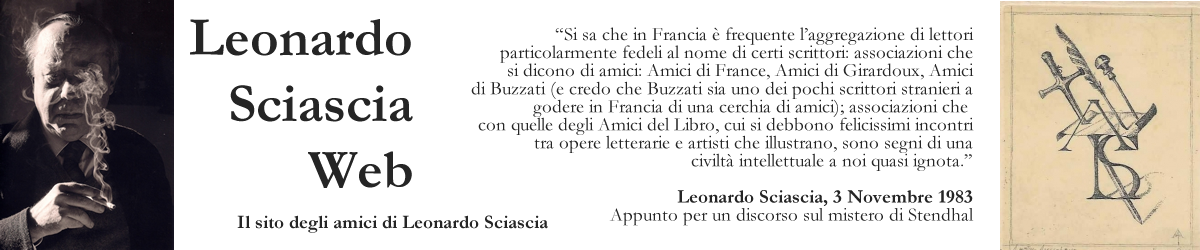Parte I
Nel dicembre 1782 Abdallah Mohamed ben Olman, ambasciatore del Marocco alla corte di Napoli, sulla rotta del ritorno in patria fa naufragio sulle coste siciliane e viene accolto a Palermo dal viceré Domenico Caracciolo. Non potendo comunicare con l’inatteso ospite, ignaro del francese e anche del napoletano, il viceré lo affida al maltese don Giuseppe Vella, l’unica persona che in città abbia fama di conoscere l’arabo, e che vive modestamente dei proventi di fracappellano dell’Ordine di Malta e di numerista del lotto, o «smorfiatore di sogni». Poiché il diplomatico chiede di vedere «tutto quel che in Palermo c’[è] di arabo», al Vella, che funge da interprete, si unisce monsignor Airoldi, amante della storia siciliana e delle cose arabe. L’ospite viene anche intrattenuto in serate «che dolcemente trascorr[ono] tra bellissime donne, incanti di luci, di sete, di specchi, toccante musica, soavissimo canto; e le delicatezze della tavola, l’illustre compagnia». Finalmente, quando Abdallah Mohamed ben Olman viene condotto al monastero di San Martino, dove da un secolo si trova un misterioso codice arabo, delude le attese di monsignor Airoldi dichiarando che si tratta soltanto di «una vita del profeta… niente di siciliano: una vita del profeta, ce ne sono tante». Ma il pensiero di dover rinunciare alla bella vita che ha appena assaporato fa scattare nella mente di Giuseppe Vella – che dell’arabo ha in realtà una scarsa conoscenza – l’idea di farsi «protagonista della grande impostura»: “traducendo” le parole del diplomatico, afferma infatti che il codice è una preziosa raccolta di documenti riguardanti la Sicilia.
Partito l’ambasciatore, di cui non ricorda nemmeno il nome – lo ribattezza infatti Muhammed ben Osman Mahgia – Vella si vede offrire da monsignor Airoldi il compito di tradurre il codice martiniano: in cambio di una casa adatta al lavoro che dovrà fare – Vella abita nella scomoda e rumorosissima casa della nipote – e di «altri segni della […] benevolenza» di monsignore. Tornando a casa, Vella pensa a come costruire il suo codice, alle fonti delle quali servirsi.
Monsignor Airoldi conduce con sé Giuseppe Vella nei salotti della nobiltà palermitana. Durante una di queste serate, il viceré Caracciolo viene attaccato per il rogo dell’archivio dell’Inquisizione. L’unico a difenderlo è l’avvocato Francesco Paolo Di Blasi, a sua volta visto con sospetto e anche con disprezzo per le sue idee illuministe. Durante la conversazione, il poeta Giovanni Meli dice a Vella che «Don Rosario Gregorio va dicendo cose dell’altro mondo: che non sapete una parola di arabo, che il contenuto del codice di San Martino voi lo state inventando di sana pianta…». Ma Vella ribatte con freddezza e umiltà e, quando si è allontanato, viene difeso da monsignor Airoldi, che lo considera assolutamente incapace di un’opera del genere, «un uomo senza cultura, sprovveduto… E dunque come può, un uomo simile, costruire dal nulla tutto un periodo di storia che, bene o male, io sono in grado di verificare?… Credete a me: Vella l’arabo lo conosce. E vi dico di più: conosce soltanto l’arabo, nel nostro volgare non è nemmeno capace di metter su una lettera».
Da parte sua, nella pace e tranquillità della sua nuova casa, trasformata in «un antro di alchimia», Giuseppe Vella lavora con metodo. Dopo aver «dislegato» il codice di San Martino, ne mischia i fogli e li rimonta in modo assolutamente casuale. Non si limita a questo, ma apporta ai caratteri arabi delle modifiche – «aste leggere e vibratili come zampe di mosca, puntini, […] uncini e cediglie» – trasformandoli in quelli che definisce caratteri mauro-siculi. E dopo aver così corrotto il codice, si dà al lavoro, intellettualmente faticosissimo, della «creazione dal nulla o quasi dell’intera storia dei musulmani di Sicilia»: in altre parole, a trasformare il codice di San Martino nel suo Consiglio di Sicilia. E ad allontanare i dubbi che a monsignor Airoldi di tanto in tanto si presentano, arriva una medaglia, «dono del memore ambasciatore marocchino, ma [che] a don Giuseppe era costata, come opera prima, immane fatica a farla in casa».
I tentativi di riforme del viceré Caracciolo – tra cui un nuovo censimento e un nuovo catasto, con timori di possibili, inaudite imposte a carico della nobiltà – vengono sprezzantemente definiti caracciolate. Particolare indignazione riscuote – tra la nobiltà e la plebe – l’ipotesi di ridurre da cinque a tre giorni i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, per poter destinare i denari così risparmiati alla ricostruzione di Messina, colpita da un grave terremoto: «ognuno pensi ai casi suoi, e se Messina ha avuto un disastro se lo tenga e provveda da sé… I messinesi! Gente che ha tentato sempre di fottere Palermo…» . Se ne parla nel circolo di piazza Marina, in cui l’avvocato Di Blasi e la contessa di Regalpetra vicendevolmente si corteggiano, parlando de Les bijoux indiscrets di Diderot. Dopo di che, Di Blasi si unisce ad un gruppo composto da monsignor Airoldi, dal marchese di Villabianca e dal Vella, che parlano dell’istituzione di alcune cattedre presso l’Accademia degli Studi di Palermo, tra cui una di arabo, naturalmente destinata a don Giuseppe Vella. Il quale preferirebbe «una doviziosa prelatura… una rendita ecclesiastica tra le più ricche e sicure», ma al tempo stesso è attratto dall’idea «di allargare e complicare il suo giuoco, di muoversi su una più spericolata trama, mandando avanti una scuola, tutta una scuola su una lingua araba fondata praticamente da lui, da lui creata…».
La festa di Santa Rosalia, a scorno del viceré, dura cinque giorni. In compenso scoppia una carestia che a Palermo, dove il pane è soggetto a calmiere, praticamente non si sente. E tantomeno la sentono la nobiltà e don Giuseppe Vella, che della nobiltà è ospite fisso, e il cui nome è ormai conosciuto in tutta l’Europa colta, che attende la pubblicazione della sua opera. Il Vella, sempre più sicuro di sé, giunge al punto di far circolare la voce di aver ritrovato, in traduzione araba, i diciassette libri di Tito Livio mancanti. L’invenzione dei libri di Tito Livio viene però rimandata e sostituita dall’idea di un nuovo progetto, che diventerà il Consiglio d’Egitto. L’idea gli è stata suggerita dal tentativo del viceré di «incenerire tutta la dottrina giuridica feudale, tutto quel complesso di dottrine che la cultura siciliana aveva in più secoli, ingegnosamente, con artificio, elaborato per i baroni, a difesa dei loro privilegi…». Lui, Vella, col suo nuovo codice arabo avrebbe dimostrato che non era vero quanto baroni e giuristi affermavano, ossia che la conquista normanna della Sicilia da parte del re Ruggero era stata una sorta di «impresa commerciale, il re qualcosa di simile al presidente di una società». Di tutt’altra cosa si era trattato: «tutto alla Corona, e niente ai baroni»; e questo, certificato dalla «testimonianza diretta e disinteressata degli arabi». Si tratta ora, per don Giuseppe Vella, di stendere il suo testo in italiano, per poi tradurlo in arabo – nel suo arabo. E per documentarsi sulla storia costituzionale della Sicilia, comincia a frequentare l’avvocato Di Blasi e i suoi due zii benedettini, Giovanni Evangelista e Salvatore. Ma il canonico Rosario Gregorio non demorde: lo punzecchia su talune incongruenze del suo testo – «… so che ha già fatto dei grandi progressi a convertire i musulmani di Sicilia, a farli comportare da cristiani» – e con l’obiettivo di smascherarlo si mette « addirittura a studiare l’arabo, da solo».
In una conversazione alla Marina, cui prendono parte tra gli altri il poeta Meli, Di Blasi e Vella – che comincia ad essere chiamato “abate” senza esserlo ancora – si scambiano salaci pettegolezzi sui costumi della nobiltà palermitana, e si critica il viceré Caracciolo, difeso come sempre da Di Blasi: «…Quest’uomo, mi dico, ha conosciuto Rousseau, ha conversato con Voltaire, con Diderot, con D’Alembert… A proposito: sapete che Diderot è morto? Il trentuno del mese scorso…».
Completata la trasformazione del codice di San Martino nel Consiglio di Sicilia, don Giuseppe Vella si dedica alla stesura del Consiglio d’Egitto. Per farsi aiutare nel lavoro materiale, fa venire da Malta il monaco Giuseppe Cammilleri, «uomo della sua stessa pasta: ma di mente gretta e lenta, di appetiti elementari ed immediati. In quanto a mantenere un segreto, una tomba…». Assolutamente fidato, quindi, ma da pagare con denari che il monaco spende con una cassariota, che riceve in casa durante le assenze di Vella. Questi pensa che tra qualche secolo, ormai svelata la sua impostura, rimarrà la sua opera, il suo romanzo dei musulmani di Sicilia. Cammilleri, pur ammirando l’impostura, non è tuttavia in grado di apprezzare l’invenzione, l’opera letteraria: e con Vella parla di donne, dal monaco praticate ma non capite, da Vella soltanto vagheggiate. E a Cammilleri, che ogni tanto viene preso dagli scrupoli per la sua complicità nell’impostura, Vella risponde che «il lavoro dello storico è tutto un imbroglio, un’impostura: e che [c’è] più merito ad inventarla, la storia, che a trascriverla»; e che pertanto il loro lavoro meriterebbe ben più di quello che va in prebende allo storico di professione.
Nel corso di un convegno d’amore, naturale seguito della loro conversazione su Les bijoux indiscrets, la contessa di Regalpetra chiede all’avvocato Di Blasi una raccomandazione presso don Giuseppe Vella: il marito di lei teme infatti che le notizie eventualmente contenute nelle due opere di Vella possano mettere a rischio i suoi diritti su un feudo. Di Blasi la rassicura.
In un salotto, don Gioacchino Requesens ascolta monsignor Airoldi leggere un passo del Consiglio di Sicilia riguardante Racalmuto, di cui i Requesens sono conti. Il nobiluomo, preoccupato, chiede se anche nel Consiglio d’Egitto vi siano notizie sul paese. Giuseppe Vella, anch’egli presente, resta nel vago: il che fa temere il peggio a don Gioacchino. Questi crede di essere il primo ad intuire il pericolo che il Consiglio d’Egitto può costituire per gli interessi dell’aristocrazia, ma non sa che la casa di Vella è inondata da ogni genere di regalie da parte dei nobili palermitani, che fanno a gara per ingraziarsi il fracappellano.
Alla festa organizzata per salutare il viceré Caracciolo, richiamato a Napoli, il personaggio più vezzeggiato è Giuseppe Vella: il quale rassicura Di Blasi in merito alle preoccupazioni della contessa di Regalpetra, lasciando nell’avvocato la spiacevole impressione di essere disposto a sacrificare un documento storico all’amicizia. Ma nonostante la grande affezione che i presenti gli dimostrano, Vella è disposto ad attribuire, agli antenati di coloro che lo gratificano di cadeaux, prestigiose parentele e cariche importanti, ma non feudi: lui «lavorava per la Corona, dalla Corona si aspettava in premio un’abbazia o altro beneficio sine cura; così come aveva già ottenuto una cattedra e una borsa di mille onze per un viaggio di studio in Marocco, che si preparava ad effettuare». Quanto a Caracciolo, parte da Palermo con la speranza – l’illusione – di aver lasciato un segno di quel che sarebbe possibile e si dovrebbe fare per migliorare la vita della Sicilia, ma è uno sconfitto. E salutando Di Blasi, dopo avergli chiesto del suo lavoro sulle prammatiche, gli chiede «con un sorriso d’intelligenza “Come si può essere siciliani?”».
Parte II
In una lettera indirizzata al re, Giuseppe Vella, dopo aver ricordato la sua traduzione del codice martiniano, ovvero del Consiglio di Sicilia, che illumina la storia dell’isola sotto il dominio arabo, gli presenta la sua nuova opera, traduzione di un codice inviatogli – insieme a vari fogli mancanti del codice martiniano e a molte medaglie – da Muhammed ben Osman Mahgia, già ambasciatore del Marocco a Napoli. Il Consiglio d’Egitto contiene «tutte le lettere di affari, che per lo spazio di presso a quarantacinque anni furono scritte tra’ Sultani d’Egitto, il famoso Roberto Guiscardo, il Gran Conte Ruggiero, ed il di lui figlio dello stesso nome, che fondò poi la Monarchia della Sicilia, e prese il primo titolo Reale». Dopo aver sottoposto alla visione del viceré Caramanico alcuni saggi della sua traduzione, ne ha ottenuto l’incoraggiamento a continuare nel suo lavoro. Non gli resta ora, quindi, che presentare a Sua Maestà la traduzione del testo arabo, sottolineando la sua particolare importanza per quanto concerne i diritti della Corona nel Regno di Sicilia: «Ma quel che più mi fa sperare, che debba renderlo meritevole della Vostra Augusta protezione egli è, o Sire, che i Supremi diritti della Regalìa non altrove quanto in esso ampiamente rilucono; conciossiacché nelle due legislazioni, che vi sono inserite, e particolarmente nella seconda tutto ciò, che al pieno, ed inalterabile dominio dei reggitori di questa Monarchia fu riservato, partitamente si legge…». Quando infine non gli sarà più necessario consultarlo, donerà alla Biblioteca Reale il codice arabo originale, insieme alla sua importante raccolta di monete e vasi arabi. E ringrazia infine i suoi corrispondenti in Marocco e «D. Francesco Carelli Segretario di questo Governo di Sicilia».
Parte III
Nel corteo che segue il solenne funerale del principe di Caramanico, viceré di Sicilia per circa dieci anni, l’abate Giuseppe Vella non pensa ai sospetti che corrono sulla morte del viceré, ma a quelli che Rosario Gregorio sparge sulla sua opera. Per sua fortuna, Vella è difeso dall’autorevolissimo orientalista Tychsen, professore a Rostock, al quale i suoi nemici hanno contrapposto un certo Hager, fatto venire in Sicilia a spese del re. Palermo è tutta dalla parte di Vella, al punto che Gregorio teme per la sua incolumità. Vella è intanto «il grande Vella»: è stato fatto socio dell’accademia di Napoli, il papa in persona si è preoccupato per la salute dei suoi occhi. Ma quando Hager, incaricato dal governo, chiede di vedere tutto il materiale su cui Vella ha lavorato, nel corso di una notte l’abate lo fa sparire, trasferendolo a casa della nipote e quindi denunciandone il furto.
La casa di Vella viene perquisita dagli sbirri, guidati dal Grassellini, giudice del Real Patrimonio. Questi – convinto che il furto sia soltanto una messa in scena – gli spiega che la competenza sul fatto è stata tolta alla Corte Criminale perché la documentazione rubata apparteneva al Regno: tesi sulla quale Vella concorda, aggiungendo che teme per la sua sicurezza. Ma Grassellini sornionamente lo rassicura, dicendogli che la sua casa sarà sorvegliata giorno e notte. Quanto all’assenza del suo assistente Cammilleri – da lui mandato a nascondersi nel villino che ha acquistato a Mezzomonreale –, Vella spiega che l’ha scacciato da tempo, perché l’ha sorpreso con una donnaccia. Grassellini, che anni addietro si era schierato dalla parte del viceré Caracciolo, arrivando ad organizzare per lui la festa di addio, sente che i tempi stanno per cambiare e che l’inchiesta sul Vella può fargli guadagnare le simpatie del nuovo potere. L’abate, dopo aver scritto al ministro Simonetti – vecchio amico del viceré Caracciolo, che aveva seguito a Napoli – lamentando il «martirio» cui è stato sottoposto dal Grassellini, si mette a letto, fingendosi malato.
Sulla gravissima malattia del Vella nobili e plebei palermitani sono divisi: chi crede sia vera, chi invece pensa si tratti di una montatura, come il furto. I dubbi di molti nobili sono ammorbiditi in favore dello studioso, ma soprattutto dal pensiero del ricattatore ancora potente. Se ne discute a palazzo Cesarò, dove il marchese di Villabianca spinge i presenti a valutare cosa accadrebbe se venisse provata la falsità dei codici dell’abate Vella: la Corona dovrebbe rinunciare a tutte le sue rivendicazioni basate sul Consiglio d’Egitto. E di cosa si tratta lo spiega bene il marchese di Geraci: «E che cosa non ha dato alla Corona, col Consiglio d’Egitto? Spiagge, feudi, fiumi, tonnare: tutta roba che da secoli né i re né i viceré avevano mai messo in dubbio che ci appartenesse». Ma, anche se Grassellini sta facendo un gran servizio alla nobiltà, al tempo stesso si sta rendendo colpevole di una soperchieria: e da qui risorge un sentimento di umana compassione per l’abate Vella.
Catturato nel villino di Mezzomonreale, il monaco Cammilleri viene interrogato dal Grassellini: il quale, partendo dalla storia della cassariota, poco a poco lo porta ad ammettere che il Consiglio d’Egitto è un’invenzione del Vella, il quale gliene passava un paio di fogli al giorno, da riprodurre per così dire in bella copia.
Mentre la “malattia” di Vella si aggrava, l’abate resta fiducioso nell’appoggio della Corona, che non può rischiare di perdere il Consiglio d’Egitto. Viene visitato dal poeta Meli, che è anche medico, che lo trova moribondo a causa di «un canchero allo stomaco». Gli viene somministrato il viatico, e il sacerdote che glielo impartisce confida che sta facendo «una morte da santo». Da Napoli, il ministro Simonetti ordina che la Corte Criminale avochi a sé l’inchiesta sul furto delle carte del Vella, togliendola al Real Patrimonio. La notizia si diffonde per Palermo insieme a quella dell’improvvisa guarigione del Vella. Due giorni dopo, l’abate fa una passeggiata in carrozza che lo porta al palazzo reale, dove monsignor Airoldi gli ha fissato un incontro con il viceré monsignor Lopez y Royo, «uomo di sordida avarizia, di osceno vizio», che – disinteressato alla vicenda dei codici – gli parla soprattutto della minaccia giacobina e dei libri, «la malerba dei libri… [che] arrivano a casse, a carrettate… E tanti ne arrivano, tanti il boia ne brucia». Quanto al Vella, monsignor Lopez lo ammira, perché «se ne sta a cercare le cose del passato campando in santa pace col presente, senza il prurito di mettere sottosopra il mondo…».
Un dispaccio del ministro Acton da Napoli smentisce quello del Simonetti; e a monsignor Airoldi, nella sua veste di giudice della monarchia, viene ordinato di smascherare il Vella, ossia di «prepararsi la corda con cui sarebbe stato impiccato: impiccato alla vergogna, al dileggio, alla beffa». Ciò provoca una ricaduta nelle condizioni di salute del Vella, che però migliorano all’arrivo da Napoli di nuovi ordini, che confermano quelli del Simonetti. A questo punto, le condizione dell’abate di San Pancrazio – questo è infatti il titolo del Vella – migliorano decisamente, ed egli decide di affrontare il dottor Hager in un pubblico dibattito, che sarà diretto da cinque dotti, tutti però ignoranti dell’arabo. Hager afferma che il codice di San Martino è stato «guastato e corrotto»; e comunque, dal poco che è riuscito a interpretarne, a suo parere si tratta di una vita di Maometto. Ma dal dibattito che segue, da lui condotto con grande spudoratezza, Vella esce trionfatore.
Accompagnandoli al convento di San Martino, al termine della conferenza Vella-Hager, l’avvocato Di Blasi confessa ai suoi due zii benedettini che secondo lui Hager ha ragione. Glielo suggerisce la sua esperienza di avvocato: «Ho visto tante volte la verità confusa e la menzogna assumere le apparenze della verità…». Eppure anch’egli aveva creduto al Vella, fino al punto di citare il codice di San Martino come fonte di diritto nel suo lavoro sulle Pragmaticae sanctiones regni Siciliae. Da questa vicenda tutti escono male: l’orientalista Tychsen, monsignor Airoldi, suo zio Giovanni Evangelista, che ha scritto un libello in difesa del Vella. E del Vella pensa che, se i codici «li ha tirati fuori dal nulla, quella dell’abate è una delle più grandi fantasie del secolo». Salutati gli zii, sulla via del ritorno Di Blasi pensa a cose molto «avventate».
Le due relazioni sulla conferenza, quella della commissione e quella di Hager, vengono spedite a Napoli. L’abate Vella si gode il trionfo ma al tempo stesso si sente stanco, e decide di porre fine alla commedia di cui è protagonista. Va quindi a far visita a monsignor Airoldi e gli dimostra che il Consiglio d’Egitto è una falsificazione, scritto su una carta «fabbricata a Genova intorno al 1780», da lui acquistata qualche anno dopo a Palermo. Stravolto, monsignor Airoldi dice a Vella «Mi avete rovinato… Dovrei farvi arrestare», e gli intima di andarsene.
Nella casa dell’avvocato Di Blasi ha luogo una riunione dell’Accademia siciliana degli Oretei, fondata da suo padre, e si discute sui francesi, che secondo uno dei presenti «cominciano a rompere… Scusate… A dar fastidio, insomma». Di Blasi vagheggia una repubblica siciliana. Secondo lui, il momento storico è propizio alla caduta del vecchio ordine. Anche se il malcontento popolare è diffuso, è comunque rischioso manifestare simpatia per i francesi. Per il 5 aprile è prevista non una sommossa, ma una rivoluzione, in città e nelle campagne. Ma, mentre in casa Di Blasi si discorre della Francia, dei francesi e dell’abate Vella, un parroco ascolta «in confessione la rivelazione della congiura».
Un argentiere e un caporale – ai quali è stata promessa l’impunità – svelano i piani della congiura, il primo al confessore, il secondo ai suoi superiori: e tutti vanno al palazzo reale, dove parlano con monsignor Lopez y Royo, che ordina di arrestare i congiurati. Ma il duca di Caccamo, capitano di giustizia, rifiuta di arrestare Di Blasi perché gli è amico: «Non ho mai approvato le sue idee… Dico di più: ho orrore del suo delitto… Ma è un amico». Dell’arresto di Di Blasi si incarica l’avvocato fiscale Damiani, il quale dispone anche l’arresto di quattro compagni dell’argentiere e di due caporali. Quindi attende che Di Blasi rientri dalla sua passeggiata alla marina con due nobili amici anch’essi complici nella congiura. L’avvocato comprende immediatamente di essere perduto. Segue la perquisizione della sua casa e il suo silenzioso addio alla madre, che non vedrà più, e ai suoi libri.
La rivelazione dell’impostura di Vella, sebbene fatta a quattr’occhi, è ormai di dominio pubblico, e monsignor Airoldi – che spera che le notizie sulla congiura di Di Blasi oscurino quelle sui codici arabi – è costretto a parlarne con amici e conoscenti. La sua versione è che sì, sembra che il Consiglio d’Egitto sia una creazione del Vella, ma il Consiglio di Sicilia – pubblicato con il titolo Codex diplomaticus Siciliae sub saracenorum imperio ab anno 827 ad 1072, nunc primum depromptus cura et studio Airoldi Alphonsi archiepiscopi Heracleensis – è assolutamente genuino. Tra i nobili, intanto, si discute della congiura del Di Blasi, che proprio quel giorno, giovedì santo, doveva scoppiare: «… le chiese erano per prime destinate al saccheggio… poiché il giovedì santo le chiese mettono in parata tutti i loro tesori». Questa, infatti, è la versione inventata da monsignor Lopez y Royo, che trova subito credito e diffusione per colpire il sentimento popolare. Ci si chiede come sia stato possibile che nessuno si sia reso conto di quanto Di Blasi andava tramando, di quali fossero le sue idee; al che il marchese di Geraci commenta: «… L’abbiamo scampata per un pelo, sapete? Senza l’intervento della Provvidenza, a quest’ora le idee giuocherebbero a bocce con le nostre teste». E conclude dicendo che questa è l’occasione buona «per ripulire del tutto la stalla: l’abate Vella incluso». Timidamente monsignor Airoldi obietta che si tratta di altra faccenda.
Di Blasi è sottoposto alla tortura della corda, ma si impone di resistere e non parlare. Discolpa gli altri arrestati, della cui fiducia ha approfittato, e aggiunge che non ve ne sono altri. Mentre subisce la corda per la seconda volta, ricorda che circa due secoli prima il poeta Antonio Veneziano subì sette tratti di corda, « e tinni». Il giudice minaccia di ricorrere ad altri mezzi, e lui ribatte: «Lo so: la veglia, il fuoco… Lo so. La stupidità umana ha trovato in questo campo una straordinaria inventiva…». E aggiunge che, ammesso che col tormento riescano a fargli ammettere di conoscere un certo colonnello Ranza, «in questa tregua, voglio dirvi sulla mia parola, da uomo a uomo, che io non ho mai sentito nominare il colonnello Ranza». Gli viene inflitto il terzo tratto di corda.
Dalla nipote, informata dal marito, e dal messaggero di monsignor Airoldi, Vella apprende dell’arresto di Di Blasi. Si reca al convento di San Martino, a manifestare la sua solidarietà ai due zii benedettini dell’avvocato. Lo riceve padre Salvatore, nella biblioteca: dove tutta l’impostura era cominciata. Vella dice di non credere alla notizie calunniose che circolano in città a proposito del progettato saccheggio delle chiese, ma lo zio, che lo difende su questo punto, dice che il nipote «aveva peggior disegno: voleva sovvertire l’ordine, proclamare la repubblica… La repubblica, Gesù mio, la repubblica!». Vella concorda: la repubblica era il sogno di Francesco Paolo Di Blasi. E al benedettino, che gli chiede se anche lui la pensi come il nipote, Vella risponde che per lui regno e repubblica sono la stessa cosa, e che dell’esistenza di re, consoli o dittatori non gliene importa nulla, ma «Per la rivoluzione, ve lo confesso, ho invece un sentimento diverso: quel levati tu che mi ci metto io, che ci posso fare? mi piace… I potenti che vanno a intanarsi e i miseri che fanno trionfo…». Nel salutarlo, don Salvatore dice a Vella – al quale la rivelazione fa molto piacere – che suo nipote aveva sospettato la sua impostura proprio la sera in cui l’abate aveva «annientato Hager».
Di Blasi viene torturato sette volte con il fuoco, dopo aver subito cinque volte la corda e per quarantotto ore la veglia. Steso sul tavolaccio della cella, da cui i piedi sporgono per non accrescere la sua sofferenza, medita sulla tortura e sulle sue conseguenze sull’animo umano. Ripensa alla madre, a certe visioni e sensazioni della sua vita. Pensa anche a Vella: «Ha declinato a suo modo l’impostura della vita: allegramente… Non l’impostura della vita: l’impostura che è nella vita… È stata un’impostura anche la tua, una tragica impostura». Pensa ai suoi tre complici, Tinaglia, La Villa e Palumbo: anch’essi non hanno parlato, hanno “tenuto”. E quanto agli altri, se sono stati vili lo sono stati per colpa sua. Spera anzi che li assolvano, e nella sua mente svolge la loro difesa.
Dal barone Fisichella, che fa da tramite tra lui e monsignor Airoldi, Vella apprende che stanno per arrestarlo, ma non mostra timore, semmai curiosità, il carcere mancando alla sua esperienza. Fisichella gli raccomanda, per conto di Airoldi, di tener duro sul codice di San Martino – autentico, incorrotto, tradotto fedelmente – e di decidere a piacer suo per il Consiglio d’Egitto, nato comunque con l’appoggio indiretto di Caracciolo e Simonetti. Vella gli chiede notizie di Di Blasi, e Fisichella risponde che «È cotto» e che il processo inizia l’indomani. Vella sa di Beccaria: la pena di morte e la tortura non lo hanno mai turbato, ma ora che un amico vi si trova di fronte «sent[e] l’infamia di vivere dentro un mondo in cui la tortura e la forca apparte[ngono] alla legge, alla giustizia: lo sent[e] come un malessere fisico, come un urto di vomito». Messi da parte comodità e piaceri, prova il gusto di offrire al mondo la rivelazione dell’impostura: in lui il letterato prende il sopravvento sull’impostore. Ricorda Malta, i suoi campanili, i bastioni, i campi, i gelsomini, e i marinai e le donne: dalla sua curiosità per la donna e i fatti erotici inizia la sua falsificazione del mondo.
A tarda sera, ai nobili riuniti a conversare in piazza Marina arriva notizia della sentenza: morte per tutti i quattro imputati, ma decapitazione per Di Blasi, forca per Tinaglia, La Villa e Palumbo. Soddisfazione di tutti: per l’esemplarità delle condanne, e per la distinzione accordata a Di Blasi, che comunque sentono come uno di loro. Nobili e camerieri discutono dei vantaggi della decapitazione, ma in genere preferirebbero evitarla, per non essere tagliati in due. La contessa di Regalpetra, memore della loro relazione, dice che Di Blasi alla sua testa ci teneva, mentre secondo un interlocutore la distinzione accordatagli di sicuro accresce la pena dell’avvocato, che voleva l’uguaglianza. E alla contessa, che teme di non riuscire a dormire, consiglia un decotto di lattuga, con un po’ di limone.
Dopo diciassette giorni di carcere, Vella viene informato dal cappellano che Di Blasi è stato condannato a morte e che l’esecuzione avrà luogo l’indomani: «A meno che non sia falso il proverbio che dice che per boia non manca mai». Il boia si è infatti infortunato allestendo la forca, ed è quindi necessario trovare un sostituto. Vella chiede al cappellano, che pure sa essere una spia, di salutare Di Blasi da parte sua: «Dirgli… Ecco: che di quello che ho fatto sono pentito… I codici, voi capite… Sì, pentito: e desidero che lui lo sappia: e che… Niente: che sono pentito, che lo saluto». Tuttavia tra sé pensa che non è pentito affatto. Il cappellano promette che riferirà e si offre di fargli vedere Di Blasi, che poco dopo sarà condotto via per un’ultima sessione di tortura, prevista dalla sentenza. Lui, Vella, si metterà in una posizione tale che Di Blasi possa vederlo, alzando gli occhi, prima di salire sulla carrozza. Mezz’ora dopo infatti Vella lo vede, incanutito e quasi irriconoscibile: si salutano, Di Blasi togliendosi il cappello, Vella agitando il breviario. Poco dopo, il cappellano informa Vella di aver riferito il messaggio, e che Di Blasi gli ha risposto «che la vita ha tante imposture che la vostra ha almeno il merito di essere allegra e anche, in un certo senso, così mi ha detto, utile. E che ammira la vostra fantasia… E che vi augura torniate presto in libertà, e che vi saluta». Quanto al boia, i proverbi si dimostrano sempre veri: il sostituto è stato trovato.
Di Blasi subisce l’ultima tortura: lardo bollente che gli viene sgocciolato sui piedi da un secondino che si è offerto volontario, con l’alibi mentale di far soffrire meno il condannato. Anche i giudici cercano di non guardare, tutto sommato infastiditi dall’incombenza: tra poco torneranno a casa, in famiglia, tra i loro affetti. Di Blasi si illude che tutto questo non accadrà più, in un mondo finalmente illuminato dalla ragione. (E morirebbe disperato se potesse immaginare che in futuro popoli e uomini civilissimi ne stermineranno milioni di altri, e che addirittura i più diretti eredi della ragione riporteranno nel mondo la questione.) Terminata la tortura, Di Blasi è riportato in prigione, dove viene affidato al conforto dei Bianchi; ma, per sfuggire alla cure di un confortatore insopportabile, si mette a scrivere dei versi.
L’abate Vella scrive al re una lettera in cui, negando i falsi, implicitamente li ammette: «Bisogna dunque convenire che se io non avessi fatto altro che indovinare o fantasticare, non si poteva indovinare più giusto, né fantasticare con più vigore; e che il creatore di così singolari opere sarebbe, mi permetto di dirlo, degno di ben altra fama che il traduttore modesto di due codici arabi…». La lettera tranquillizzerà monsignor Airoldi. Le campane che suonano a morto indicano che Di Blasi sta salendo sul palco. La piazza è quasi deserta e vi fa spicco il dottor Hager, che attira lo sguardo del condannato. Il palco è addobbato di nero, con candele nere, e il più giovane servo della sua casa, in livrea di lutto, tiene il bacile d’argento in cui cadrà la testa di Di Blasi, che pensa che nemmeno la madre ha saputo capirlo. E al boia volontario, che si risparmia sedici anni di galera e gli chiede perdono, risponde di pensare alla sua libertà. Nel suo ultimo sguardo sulla piazza, scorge ancora il dottor Hager, «attento come se stesse decifrando una pagina del codice di San Martino».
*
Il Consiglio d’Egitto – certamente uno dei vertici, e forse il vertice assoluto della narrativa sciasciana – è, in un certo senso, un libro nato per caso. In La Sicilia come metafora, libro-intervista con Marcelle Padovani del 1979, Sciascia afferma che «Il Consiglio d’Egitto è stato […] scritto al posto di un altro libro; volevo fare la cronaca del massacro dei presunti giacobini, avvenuto a Caltagirone alla fine del XVIII secolo, e avevo cominciato a documentarmi sull’argomento. Scorrendo la storia letteraria della Sicilia di Domenico Scinà, raccogliendo il materiale rimasto negli archivi, e poi leggendo le Cronache del marchese di Villabianca, mi si è imposta la figura dell’abate Vella…». In altri scritti e interviste (da Paolo Squillacioti esaustivamente indicati nelle sue Note ai testi in L. Sciascia, Opere, Volume I: Narrativa Teatro Poesia, Milano, Adelphi 2012, pp. 1793-1816), Sciascia fornisce altre indicazioni sulla genesi del romanzo.
La narrazione dell’impostura dell’abate Giuseppe Vella (1749-1814) e della congiura dell’avvocato Francesco Paolo Di Blasi (1755-1795) segue fedelmente lo svolgersi degli avvenimenti storici: dalla scena iniziale, nella seconda metà del dicembre 1782, al giorno in cui Di Blasi viene decapitato, mercoledì 20 maggio 1795.
Il romanzo, diviso in tre parti, copre quindi un periodo di circa dodici anni e mezzo. La prima parte, composta da undici capitoli, si snoda per poco più di tre anni, dal dicembre 1782 al gennaio 1786, ed è interamente dedicata a Giuseppe Vella e alla sua impostura. I fatti storici che la delimitano sono il fortunoso arrivo a Palermo dell’ambasciatore del Marocco, e la partenza, da Palermo per Napoli, del viceré Domenico Caracciolo.
La seconda parte consiste nella lettera con cui Giuseppe Vella presenta al re il Libro del Consiglio di Egitto tradotto da Giuseppe Vella cappellano del sacro ordine gerosolimitano, abate di S. Pancrazio. Palermo dalla reale stamperia, 1793, tom. I in-fol.
La terza parte, strutturata in diciannove capitoli, inizia nel gennaio 1795 con la morte del viceré Caramanico e prosegue, con ritmo incalzante, fino a concludersi tragicamente circa quattro mesi più tardi. In questo brevissimo spazio di tempo, mentre viene smascherata l’impostura del Vella, quasi contemporaneamente nasce, e si conclude sul patibolo, l’avventura politica del Di Blasi.
Grazie ai moltissimi episodi storicamente verificati, e fedelmente riportati nel romanzo, è possibile stilare una cronologia, in taluni casi molto precisa, de Il Consiglio d’Egitto.
Le vicende narrate in dieci dei diciannove capitoli della Parte Terza (II, VII, VIII, X, XI, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX) si svolgono in date che è possibile determinare con la massima esattezza. In altri cinque capitoli (III della Parte Prima e IV, V, VI e IX della Parte Terza) l’approssimazione temporale è ridotta a pochi giorni o, in ogni caso, ad alcune settimane. In un buon numero di casi (Parte Prima I, II, V, VI, VII e XI; Parte Terza I, III, XII, XIII e XIV), i fatti narrati si svolgono in un mese determinato. Soltanto tre capitoli (VIII, IX e X della Parte Prima), peraltro di carattere squisitamente narrativo, non offrono indicazioni che ne consentano una sia pur approssimativa datazione. I fatti narrati nel IV capitolo della Parte Prima, infine, si svolgono in realtà nel 1784.
PARTE PRIMA
Cap. I Dicembre 1782
Cap. II Gennaio 1783
Cap. III Fine giugno 1783
Cap. IV (1784)
Cap. V Luglio 1783
Cap. VI Luglio 1783
Cap. VII Agosto 1784
Cap. VIII (1784 - 1785)
Cap. IX (1784 - 1785)
Cap. X (1785)
Cap. XI Gennaio 1786
PARTE SECONDA
1793
PARTE TERZA
Cap. I Gennaio 1795
Cap. II 11 gennaio 1795
Cap. III Gennaio 1795
Cap. IV Metà gennaio 1795
Cap. V Fine gennaio - inizio febbraio 1795
Cap. VI 7 - 22 febbraio 1795
Cap. VII 22 febbraio 1795
Cap. VIII 21 marzo 1795
Cap. IX Fine marzo 1795
Cap. X 31 marzo 1795
Cap. XI 2 aprile 1795
Cap. XII Aprile 1795
Cap. XIII Aprile 1795
Cap. XIV Aprile 1795
Cap. XV 2 maggio 1795
Cap. XVI 18 maggio 1795
Cap. XVII 19 maggio 1795
Cap. XVIII 19 maggio 1795
Cap. XIX 20 maggio 1795
Euclide Lo Giudice
Pubblicato per la prima volta nel 1963, nella collana einaudiana “I Coralli” (n. 171), il romanzo è disponibile nell’edizione della collana “Fabula” (n. 32) di Adelphi del 1989 e successive ristampe, e nelle due raccolte delle opere: L. Sciascia, Opere 1956-1971, a cura di Claude Ambroise, Milano, Bompiani 1987, pp. 485-641 e L. Sciascia, Opere, Volume I: Narrativa Teatro Poesia, a cura di Paolo Squillacioti, Milano, Adelphi 2012, pp. 345-499.
L’omonimo film del 2002, diretto da Emidio Greco su una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con Lorenzo Greco, è interpretato, nei ruoli principali, da Silvio Orlando (Giuseppe Vella), Tommaso Ragno (Francesco Paolo Di Blasi), Renato Carpentieri (monsignor Airoldi), Marina Delterme (la contessa di Regalpetra).
5 gennaio 2014